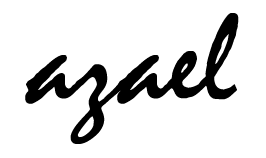Per capire quanto fosse educato e pacato Luciano Rispoli si consideri solo questo piccolo aneddoto: una mattina di primavera di fine anni 80, forse l’88, Luciano era in aeroporto ad attendere il volo per Milano; un ragazzino, scappato rapidamente dal controllo della madre, gli si avvicina — forse avendolo riconosciuto come “il signore che sorride in tivvù” — e, con la spontaneità dei bimbi, gli dice “‘ignore, io ‘i conosco, io ‘i conosco” e il buon Luciano, quasi senza muovere le articolazioni del robusto collo, “non sono io, l’uomo che hai riconosciuto in TV, ma ‘ei ‘u ‘tesso”. Luciano Rispoli, signore d’altri tempi, di buona famiglia e di natali nobili, come solo certe discendenze del sud sanno ancora onorare, era un uomo buono, ma non pregno di certo vittimismo italiano. Scappato di casa già a 7 anni per rincorrere il “sogno folle” di costruire un futuro migliore per il suo “‘opolo”, si formò alla scuola di drammaturgia e canzone di Via Rasetta a Roma, proprio quella stessa in cui — anni dopo — Mogol scrisse i versi immortali de “Il melangolo”. “Quando l’amore / senza le porte / attende il ritorno / di chi non ha cuore”, amore/porte/ritorno/cuore, il destino di Luciano era già scritto in questi punti cardinali dell’amor cortese. Sarà stata l’atmosfera di fine secolo, certe naturali melancolie alla Chateaubriand, ma Luciano scelse, e dico scelse porcoddio, di alzare la posta. Basta canzonette, copioni di commediole spediti in giro per l’Italia a raccimolare gesti di approvazione e nessun doblone, basta perdere tempo: azione! Movimento-Ritmo-Rivoluzione. Luciano ritornò nella sua Calabria clandestinamente, con diversi altri esiliati, navigando dal Messico a Cuba su una piccola imbarcazione, il Granma, salpata da Roma il 25 novembre 1956 e approdata nella provincia di Oriente, dove il 2 dicembre si svolse la prima azione del gruppo, che volle chiamarsi il Movimento Melba. Solo dodici degli ottanta uomini, tra cui Ernesto “Che” Guevara, Raúl Castro e Nunzio Filogamo, sopravvissero alla ritirata sulle montagne della Sierra Maestra, e da lì cominciarono la guerriglia contro il governo di Batista. Poi da lì, come spesso avviene, come se il tempo fosse lì ad aspettare un cenno, i mille successi che conosciamo: Pomeridiana, Il gioco dei mestieri, Intervista con la scienza, Pranzo in TV, Casa Rispoli, la Moncada, Parola mia. Parola mia, signori. Questa rivoluzione popolare, questo nuovo modo, questo pacato rimescolamento dei costumi. Ma, su tutto, questa invenzione: il preserale. Parola mia è stato un programma televisivo a quiz sulla lingua italiana, composto da tre rubriche: Conoscere l’italiano, Usare l’italiano, Amare l’italiano. I concorrenti si sottoponevano a delle prove che riguardavano etimologie, significati delle parole, modi di dire, sinonimi e contrari, la stesura di un pezzo di tipo giornalistico e l’analisi di brani letterari interpretati da grandi attori di prosa. Questo è quello che cinquant’anni di malgoverno DC hanno cercato di far passare come verità storica. Niente di più falso. Parola mia era innanzitutto un preserale. Un fottuto preserale, forse il primo vero preserale. Con tutto ciò che questa maledetta parola insaguinata ha rappresentato per questo secolo. “Un preserale non è un letto di rose. Un preserale è una lotta tra il futuro e il passato”. Negli ultimi faticosi anni della sua vita, Luciano amava ripetere a Raùl che se l’Italia non avesse conosciuto il preserale, in questo Paese saremmo ancora con le vanghe alle finestre e con i buoi in fila sulla A1. Ma ogni rivoluzione conta i suoi morti. Mi ricordo che in certe sere di tarda primavera, in quegli anni formidabili, a volte ci fermavamo fuori dagli studi di Via Teulada a bere qualche birra e fumare qualche sigaro di contrabbando; io gli dicevo, per scherzare “hasta siempre, Lucià, ma intanto Pippo Baudo si sta costruendo una villa con piscina a Sabaudia”, e lui, quasi a schernirsi, “certo, ma il preserale avrà la sua villa e la sua piscina nell’apprezzamento dei telespettatori”. Quanto amava questa parola: telespettatori. Una sorta di genealogia etimologica arruffata gli permetteva di cogliere, in questo tele-aspettare, una sorta di epifania del mondo giusto, che è sempre presente, ma che sempre ha-da-venire. Ma tutto finisce, sigari, rivoluzioni e tempi spensierati. Nel 1990 Rispoli lascia la RAI per Telemontecarlo, dove inventa e conduce il longevo Tappeto volante, talk show quotidiano del pomeriggio, affiancato da Melba “Gattopardo” Ruffo. La Russia è lontana. La guerra fredda è finita. Nel preserale si aggirano orde di topi e sgualdrine. Gerry Scotti, il boom economico di ritorno, Amadeus, le puttane. Telemontecarlo era un avamposto di nostalgia. Un bel posto, un bel ricordare, ma fuori era rovina e consumismo brillante di plastica, cadaveri occultati e lustrini. Luciano lo sapeva e viveva quella seconda giovinezza come un tributo al sogno. Il comunismo ha questo di buono: serve per il fuori, ma serve ancor di più per il dentro. Luciano era strafatto di serenità. Un drogato di merda di pacata eleganza. Luciano era un feticista dell’educazione e della post-rivoluzione sussurata. Quelle tute sempre uguali con cui amava presentarsi in pubblico, quei discorsi antichi pronunciati a così basso volume che era quasi impossibile distinguere le b dalle p, quella maledetta idea di televisione e di rispetto per il pubblico. Non voglio raccontarvi i suoi ultimi anni, quelli ce li racconteranno i libri di storia; io voglio dirvi soltanto di un uomo che ha combattuto, un uomo che ha combattuto di nuovo, ha vinto, ha perso, ha rivinto, ha riperso, ha perso ancora. E quest’uomo non ha mai abbandonato il sorriso, l’amore delicato, e la sobrietà. E allora, Luciano, avevi proprio ragione, e questo secolo vigliacco non smetterà mai di ripeterlo: “non sono io, l’uomo che hai riconosciuto, ma ‘ei ‘u ‘tesso”.
Ciao Luciano.